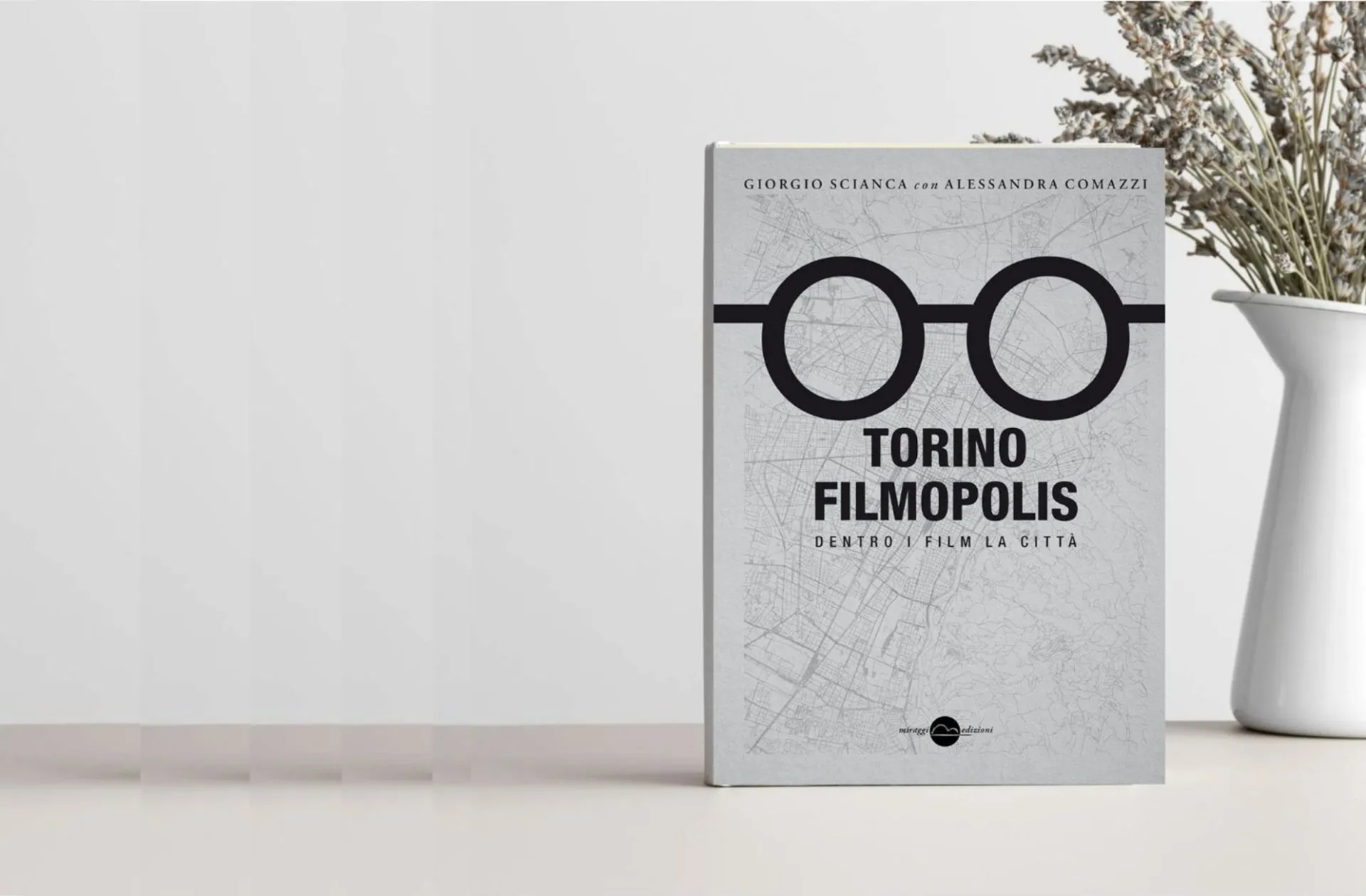Tradizioni di Carnevale del Piemonte
Da Redazione TorinoFree.it
Febbraio 06, 2018

 Durante il periodo di Carnevale, in ogni borgo e città del Piemonte ci sono tantissime tradizioni, spesso particolari e oggi dimenticate.
Durante il periodo di Carnevale, in ogni borgo e città del Piemonte ci sono tantissime tradizioni, spesso particolari e oggi dimenticate.
Tra Montà, Cisterna d’Asti, e San Damiano d’Asti si racconta la favola dell’orso: un uomo coperto di miele e piume che, ben rifornito di vino, girava la città terrorizzando i bambini, visto come un simbolo dell’antica lotta tra l’uomo e la natura selvaggia.
Una festa molto particolare è quella dei Magnin o gli stagnini, maschere originarie di Piasco, dove l’ultimo venerdì di Carnevale gruppi di giovani, con le mani e il volto imbrattati di ceneri, si divertono a sporcare chiunque incontrano sul loro percorso.
A Dusino, i contadini giocavano al barbiere, infatti, si recavano nella stalla e invece di prendere lo specchio sceglievano un setaccio e si facevano la barba con un rasoio di legno, uno faceva il barbiere e l’altro il cliente.
I partecipanti alla festa parlavano in modo strano e chi interpretava il barbè si metteva un velo sugli occhi per non farsi riconoscere.
La fine del Carnevale piemontese un tempo era celebrata con l’accensione del falò che, nella notte fra il martedì grasso e il mercoledì delle Ceneri, illuminavano le colline, dove spesso era bruciato un pupazzo rappresentante il Carnevale.
Intorno al falò si ballava, si raccontavano storie, poi iniziava il lungo periodo della Quaresima, dove tutti i lavori più pesanti della campagna sarebbero ricominciati.
Molto spesso in Piemonte il fenomeno della Commedia dell’Arte ha contribuito a portare in alcune città alcune maschere con caratteristiche e costumi particolari, molto riconoscibili.
 La più celebre maschera piemontese è Gianduja, bonaccione borghese sabaudo, amante del buon bere e del buon mangiare, ideato dal burattinaio Gian Battista Sales nel 1798, che lo aveva chiamato Gioan d’la douja o Gian con il boccale, poi abbreviato con Gianduja, con compagna la fedele Giacometta.
La più celebre maschera piemontese è Gianduja, bonaccione borghese sabaudo, amante del buon bere e del buon mangiare, ideato dal burattinaio Gian Battista Sales nel 1798, che lo aveva chiamato Gioan d’la douja o Gian con il boccale, poi abbreviato con Gianduja, con compagna la fedele Giacometta.
Il simbolo del Carnevale a Biella è Babi, uomo dispettoso che giunge in città per corteggiare le belle ragazze e per questo viene processato e messo al rogo, visto come un simbolo delle rivalità tra Biella e Vercelli.
A Vercelli sono note le maschere del coraggioso Bicciolano e la sua bella moglie Bela Majin, che si ribellarono contro i Francesi per le troppe tasse ai tempi della Rivoluzione.
Gironi e Girometta, i genitori di Gianduja, sono il simbolo dei festeggiamenti di Cuneo, mentre a Saluzzo Ciaferlin e la Castellana raffigurano i due volti della città, lui il contadino che dalle campagne arriva in città, con un grande ombrello e l’inseparabile cesta di paglia, lei, la regina delle sue contrade.
Il Moro e la Bella Monregalesa del Carnevale di Mondovì sono rispettivamente il capo dei Saraceni durante l’invasione del X secolo in Piemonte e lei la bellezza locale d’un tempo che, con l’aiuto del Moro, sposa Pietro, un altro personaggio del Carlevè, per poi fondare sulle rive del fiume Ellero la città di Mondovì.
Le maschere tradizionali di Mango, tra le colline del Moscato, sono Stangon e Concetta, che raccontano quello che succedeva negli anni Cinquanta del Novecento, dove per lo spopolamento di alcuni paesi i ragazzi dovevano sposare donne del Sud, presentate attraverso il Bacialè, un mediatore di matrimoni.
A Borgosesia molto amata è la maschera di Pèru Magunella, paladino della città, difensore della città dai Francesi e per gli abitanti il Mercoledì delle Ceneri, detto il Mercu Scur, diventa il giorno dei funerali di Pèru, tenuto dagli abitanti vestiti in frac, papillon bianco e mestolo di legno intorno al collo, per brindare al defunto in tutte le osterie disseminate lungo il percorso del Carnevale.
Articolo precedente
Alluce Valgo: cos’è e come si cura
Articolo successivo
Giovanni Arpino Dall’Istria a Torino
Redazione TorinoFree.it
Articoli correlati

Con il Rotary Distretto 2031: due Concerti “Aspettando Natale…”
Novembre 15, 2025